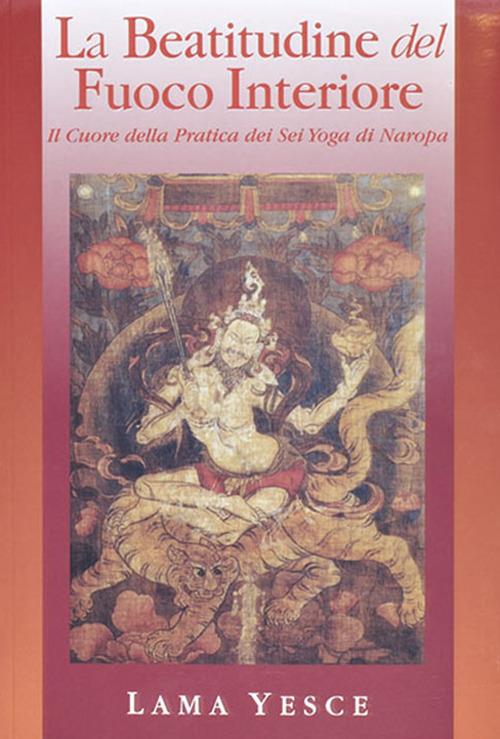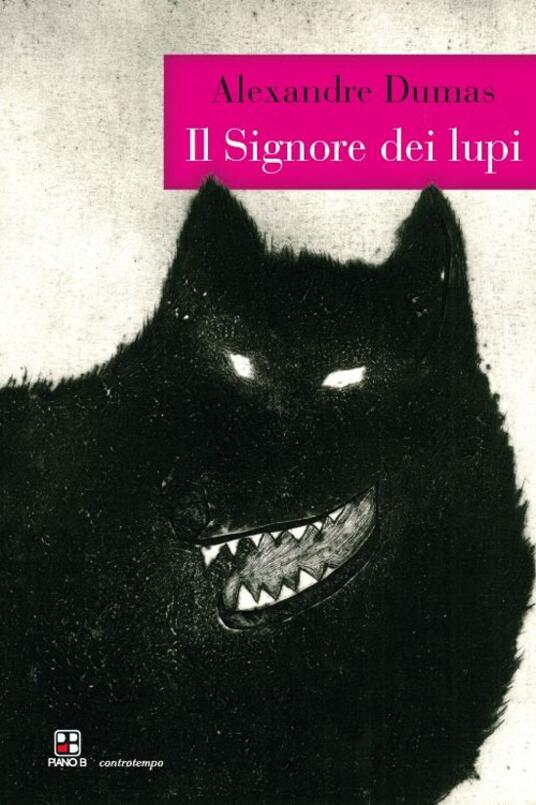|
Tra gli Stoici, come Seneca, Epitteto e Marco Aurelio, era diffusa l'idea di allontanare la paura della morte, sia personale sia dei propri cari, non solo meditando costantemente sulla vanità dell'esistenza, ma soprattutto figurandosi, in anticipo, il momento fatale.
In molti passi dei suoi Pensieri, Marco Aurelio suggerisce di compiere questa pratica focalizzandosi sull'essenza materiale del proprio corpo, visualizzando quanto di fragile, perituro e materiale esso possiede. Occorre porre in risalto la carne, le ossa, il sangue, il seme, risaltarne la "materialità" e considerarsi come un semplice agglomerato di componenti destinate a decomporsi e svanire.
Una pratica di contemplazione che, tuttavia, non deve sfociare nell'autocommiserazione, nella depressione o nel lutto. Questa scomposizione anatomica del proprio corpo, con lo scopo di porre in risalto il cadavere, ha un duplice fine: quello di prendere atto della fugacità del tempo, per vivere a pieno la propria vita, come sostiene Seneca ne La vanità della vita e nelle Lettere a Lucilio, e quello di corrodere tutto ciò che vi è di perituro e superficiale per recuperare ciò che giace sepolto sotto la carcassa materiale: la luce sempiterna dell'anima.
Il corpo può infatti diventare una tomba prematura per l'anima, quando la soffoca e la imbriglia ai propri capricci. Ma quando lo si scompone, vi si scava attraverso e lo si analizza per scoprire cosa realmente si nasconde dietro la nostra identità, ecco che la luce dell'anima rifulge e torna a splendere in tutta la sua luminosità.
Questa pratica rimarrà viva e presente anche nel mondo cristiano, fino a partire dal simbolismo originario dei Vangeli.
La passione di Cristo e le tappe via via più dolorose della via Crucis descritte nei Vangeli possono essere rilette, simbolicamente, come una progressiva scomposizione del corpo. Cristo, come Orfeo, viene smembrato non dalle Ninfe ma dai suoi aguzzini: il suo corpo è umiliato, scarnificato, sottoposto alla fatica e alle ingiurie, inchiodato alla croce ed elevato al cielo per mostrare alla folla inferocita la debolezza di una carne che suda, sanguina, soffre e piange. Ma al termine del supplizio ecco la resurrezione: dal cadavere deposto nella tomba riemerge un nuovo corpo, il corpo di luce, l'anima immortale che effonde sui fedeli i raggi del suo calore e della sua santità.
Il cristianesimo sviluppò questo simbolismo del cadavere nella pratica della contemplazione della morte. Tra gli esempi più fulgidi e ricchi anche di ironia, del sorriso beffardo tipico degli scheletri che popolano le danze macabre, vi è un passo di sant'Ambrogio di Milano, che nel suo Exameron esorta i fedeli a tendere sempre un occhio ai sepolcri per contemplare la morte: “Getta lo sguardo
dentro i sepolcri, e vedi che cosa rimarrà di te, cioè del tuo
corpo, se non cenere e ossa, e gettavi lo sguardo, ripeto, e dimmi un
po’: chi è povero e ricco là dentro? Riconoscivi i disgraziati
dai potenti! Noi tutti nasciamo nudi, e moriamo nudi. Non c’è
differenza alcuna tra i cadaveri, eccetto che, probabilmente, i corpi
dei ricchi, enfiati di tutti i piaceri, puzzano di più” (Ambrogio di Milano, Exameron, Tea Edizioni, p. 261).
La medesima "trasfigurazione spirituale" della morte e della sua immagine è stata sviluppata, in maniera parallela e autonoma, anche in Oriente, soprattutto nel Buddhismo Tibetano. E' estremamente interessante notare come pratiche del tutto affini a quelle sorte in Occidente si siano sviluppate anche tra i monasteri del Tibet, ben prima che le due culture entrassero in contatto - un'ulteriore dimostrazione di come le strade spirituali siano molteplici, ma a fronte del differente simbolismo vi siano sempre delle tecniche di manipolazione del corpo, dei pensieri e della psiche costanti, che inducono nel praticante il medesimo "sviluppo spirituale".
Nelle pratiche tantriche del Tibet, il rapporto diretto con il cadavere è una costante - come lo era stata in Occidente prima che il forte simbolismo spirituale venisse via via "annacquato" da una civiltà sempre più attaccata alla materialità della vita e intollerante nei confronti di tutto ciò che rimanda alla mortalità, in primis, appunto, la visione della morte.
Come i corpi morti dei Santi cristiani, attorno ai quali si sviluppa una vera e propria venerazione del cadavere e delle reliquie, circondati da un'aurea a metà tra il sacro e il magico, anche i corpi degli alti dignitari religiosi vengono imbalsamati ed "esposti" alla venerazione. "Queste mummie sono chiamate mardong" scrive Alexandra David-Nell nel suo Mistici e maghi del Tibet, "fasciate di stoffa, la faccia dipinta con oro, esse sono poste in mausolei di argento massiccio, ornati di pietre preziose. Spesso un pannello di vetro delimita un quadrato della bara attraverso il quale si può vedere la faccia dorata della mummia" (A. David-Neel, Mistici e maghi del Tibet, Astrolabio, p. 35), un'immagine pressoché identica ai reliquiari presenti in molte Chiese e Cattedrali occidentali, in cui il cadavere, esposto allo sguardo del fedele, diviene un vero e proprio oggetto di contemplazione, una connessione tra mondo mortale/materiale e mondo divino/spirituale.
Ma le pratiche più interessanti sono le tecniche yogiche segrete, praticate dagli iniziati al tantrismo - quello originario e non la macchietta occidentale che ha trasformato il Tantra in una banale pratica di "sesso spirituale".
Il tantrismo tibetano è una via spirituale legata alla manipolazione delle forze primordiali che attraversano l'uomo. Queste forze sono legate soprattutto ai due impulsi più potenti e tabù: l'energia sessuale e la morte. Si badi bene, però, a prendere la consapevolezza che il Tantra originario, benché coinvolga, a volte, anche pratiche sessuali, non si esaurisce esclusivamente nella consumazione dell'atto sessuale: esso è soltanto una contingenza. Ciò che il Tantra persegue è la manipolazione dell'energia sessuale e questa forza, per essere controllata, non necessità che l'atto sessuale debba essere consumato ma, anzi, prevede che tale energia venga risvegliata e controllata anche, e soprattutto, quando non è collegata alla sessualità. Similmente la visione della morte suscita uno scuotimento profondo, paragonabile allo stesso impeto mosso dalle energie sessuali e anche in questo caso il fine dell'iniziato alla via tantrica è quello di controllare queste forze primordiali per incanalarle nel proprio sviluppo spirituale.
Anche in questo caso, è sorprendente constatare come nel Buddhismo Tibetano, similmente alle pratiche di contemplazione cristiane, la morte e il cadavere divengano dei "portali di risveglio", la cui visione è in grado di elevare l'anima dell'iniziato, mobilitando nella sua interiorità delle forze ctonie.
Ne Il sentiero del mistico sacrificio, un antico testo tibetano tradotto in Occidente per la prima volta da Evans Wentz nel suo Lo Yoga Tibetano e le dottrine segrete (Ubaldini), viene descritta una pratica di visualizzazione della morte, la cosiddetta "visualizzazione del cadavere e della dea adirata", in cui l'iniziato deve figurarsi come un corpo morto smembrato e dilaniato dalla Dea Adirata. Come si legge nel testo:
"Immagina che questo corpo, che è la risultante delle tue propensioni kamiche, sia un cadavere grasso e succulento d'aspetto, immenso tanto da abbracciare l'Universo. Allora dicendo Phat! visualizza l'Intelletto radioso che è dentro di te, come fosse la Dea Adirata in piedi accanto al tuo corpo, con un volto e due mani e che impugna un coltello e un teschio. Pensa che ella recida la testa del cadavere e la ponga, come un teschio simile a un enorme calderone, sopra tre teschi sistemati come piedi di un tripode che abbraccia le Tre Regioni. E che tagli il corpo a pezzetti e li getti nel teschio come offerte alla deità. Poi pensa che dal mistico potere dei raggi dei mantra trisillabici Aum, Ah, Hum e Ha, Ho, Hri, le offerte vengano interamente trasmutate in amrita, scintillante e radioso" (Il sentiero del mistico sacrificio, in E. Wentz, Lo Yoga Tibetano e le dottrine segrete, Ubaldini, p. 313). Come nelle meditazioni di Marco Aurelio, il corpo viene suddiviso e ridotto alla mera materialità, a tal punto che ogni parte viene "reificata", trasformandosi in un oggetto sciamanico: "Questo dono è offerto con gioia grandissima" recita l'iniziato durante la visualizzazione "[...] il tamburo fatto col teschio, che è il migliore e più raro dei tamburi, possiede un suono chiaro; la coperta di pelle umana su cui viene imbandito il banchetto è meravigliosa a guardare. La tromba di femore umano emette una melodiosa nota. le campane, adornate di campanellini, e la tiara, esercitano grande fascino" (Il sentiero del mistico sacrificio, in E. Wentz, Lo Yoga Tibetano e le dottrine segrete, Ubaldini, p. 314-315).
Queste descrizioni non sono soltanto visualizzazioni legate alla sfera dell'immaginario. Esse riflettono usanze tipiche delle cerimonie funebri tibetane. Sempre come racconta Alexandra David-Neel nel suo Mistici e maghi del Tibet, durante le cerimonie funebri di alcune regioni del Tibet, il cadavere del morto può andare incontro a quattro destini differenti, tutti simili allo smembramento rituale citato in precedenza: "Il corpo è trasportato sulla cima della montagna. E' smembrato in quattro parti con un coltello ben affilato. Le interiora, il cuore, i polmoni vengono lasciati sul terreno, perché se ne nutrano gli uccelli, i lupi e le volpi. Il corpo è buttato in un fiume sacro. Il sangue e gli umori si dissolvono nelle acque azzurre. I pesci e le lontre ne mangeranno la carne e il grasso. Il corpo è bruciato. Carne e ossa e pelle sono ridotte a un mucchio di cenere. I Tisa troveranno nutrimento nell'odore. Il corpo è sotterrato. Carne, ossa e pelle saranno succhiate dai vermi" (A. David-Neel, Mistici e maghi del Tibet, Astrolabio, pp. 35-36).
Similmente, tanto nel Buddhismo Tibetano quanto nelle antiche pratiche sciamaniche del Bon, è usanze riutilizzare calotte craniche e ossa per creare oggetti rituali come coppe, flauti, trombe e "ornamenti sacri" utilizzati, come nei putridari occidentali, per avere sempre la morte di fronte ai propri occhi come monito, ricordo della vanità e dell'impermanenza delle cose materiali.
In scritti tibetani, anche più recenti, come Appunti su Il libro delle tre ispirazioni di Je Sherab Gyatso (contenuto in Praticare i 6 yoga di Naropa, a cura di G. Mullin, Amrita Edizioni), risalente al XIX secolo, è ancora presente un rapporto diretto, nelle pratiche yogiche del tantra, con il cadavere. Parlando della "pratica della proiezione della coscienza", una tecnica yogica legata alla liberazione della propria anima dal ciclo Samsarico all'insorgere della morte, Je Sherab Gyatso suggerisce di addestrarsi a proiettare la propria coscienza prima su una carcassa di maiale e poi su un cadavere recuperato da una fossa comune, finché non si diviene in grado di scaldare i corpi morti mediante la propria energia vitale.
Un'ultima pratica, meno tabù ed eseguibile anche ai giorni nostri senza il rischio di incorrere nel reato penale di villipendio di cadavere, è contenuta ne La Beatitudine del Fuoco Interiore, testo scritto da Lama Yesce (Chiara Luce edizioni) e rivolto proprio agli Occidentali desiderosi di avvicinarsi alle pratiche tantriche originarie dei Sei Yoga di Naropa.
Come nei testi tradotti da Wentz, anche il libro di Lama Yesce contiene una tecnica di meditazione del cadavere, riadattata però alla sensibilità occidentale, che prevede la visualizzazione delle differenti fasi del morire e della decomposizione del proprio corpo:
1) Nel primo stadio occorre visualizzare la decomposizione dell'elemento terra: il corpo, lentamente, si dissolve man mano che diminuisce l'energia vitale esso diventa sempre più magro e debole, e la coscienza progressivamente perde chiarezza. Le immagini e i pensieri si fanno tremolanti.
2) Nel secondo stadio avviene la decomposizione dell'elemento acqua. Il corpo si rinsecchisce, ogni liquido corporeo si asciuga, le sensazioni sonore si fanno sempre più ovattate fino a sparire. La coscienza, ora, è circondata da una cortina di fumo.
3) Nel terzo stadio si dissolve l'elemento fuoco. Il corpo si fa sempre più freddo man mano che il calore delle membra si ritira, come una candela in cui la cera è quasi giunta al termine, fino a soffocare la fiamma sullo stoppino. In questo stadio non vengono più percepiti gli odori, l'inspirazione si fa sempre più breve, debole, e l'espirazione sempre più lunga - fuoriesce dal corpo più energia di quella che, invece, viene assorbita. Il "deficit" si fa sempre più vicino. Come un ceppo giunto ai suoi ultimi singhiozzi, la coscienza emette le scintille finali.
4) Nel quarto stadio viene meno l'elemento aria. La respirazione è completamente interrotta, la lingua si fa gonfia e turgida, incapace di muoversi. La fiamma si sta spegnendo.
5) Quando tutte le porte della percezione si sono ormai spente, tutto svanisce ed ecco che sorge una nuova coscienza, non più imbrigliata ai sensi esterni. Appare un bagliore biancastro, come se si stesse contemplando un cielo completamente avvolto dalla pallida luce della luna.
6) La luce bianca si trasforma in luce rossa: la luce lunare si trasforma in luce solare, quella che tinge il del tramonto in un rosso fiammeggiante.
7) Anche il rosso svanisce e si tinge di nero, come la volta celeste quando il sole è ormai svanito. La coscienza è ora totalmente immersa nel vuoto. Ma questo è soltanto il preludio a un nuovo giorno.
8) Giunge finalmente l'ultima alba: la coscienza risorge nella "chiara luce" del mattino, paragonato da Lama Yesce alla luce dell'alba del cielo autunnale. Come scrive Lama Yesce: "Come il sole che sorge in un cielo chiaro e privo di nuvole, la luce gradualmente aumenta sempre di più, sino a quando l'intero spazio diventa chiara luce. Questa è l'esperienza del dharmakaya, lo stato di coscienza più sottile. Ogni esistenza è non duale, e tutti i problemi dualistici sono scomparsi. Entrate così nella natura simile allo spazio della chiara luce. La vostra coscienza di saggezza si fonde con lo spazio universale" (Lama Yesce, La beatitudine del fuoco interiore, Chiara Luce Edizioni, p. 81).
Daniele Palmieri